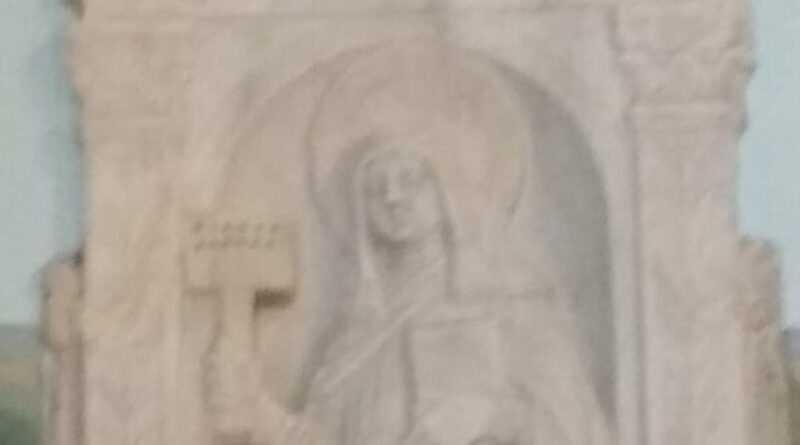Cosa resta di Limbania negli antichi luoghi della devozione
Genova. Alcuni aspetti della tradizione vedono Limbania abitare per qualche tempo a Voltri, in una casetta sulle sponde del Cerusa, per occuparsi degli infermi del vicino ospedaletto; altra tradizione la vede allo scalo genovese occuparsi dei pellegrini e dei bisognosi, tuttavia, più verosimilmente, ella non si mosse mai dal monastero di S. Tommaso in Genova. La sua fama fu portata nel genovesato e nell’entroterra attraverso viaggiatori di ogni sorta e nobili famiglie genovesi proprietarie di feudi e marchesati oltregiogo.

I confini della Repubblica genovese arrivavano almeno fino al Sassello (Matteo Vinzoni, Atlante dei Domini…, 1773). Alcune stampe sei-settecentesche raffigurano Limbania nell’atto di proteggere il porto della città. La campana1 di Santa Limbania suonava durante le tempeste per calmare i marosi e salvare le imbarcazioni in pericolo. Il nome, in uso fra le nobili famiglie, resta nella calata Santa Limbania, nei pressi della stazione marittima, un tempo cuore degli imbarchi di tante merci ed emigranti. Vicino, sul promontorio di Caput Arenae, era il monastero di S. Tommaso, dove Limbania trascorse la vita.
Voltri. Antico e odierno luogo di devozione (voltrese, come supporrebbe una leggenda, era il capitano della nave di Limbania). A Voltri si trova, nella piazzetta omonima, l’oratorio di Santa Limbania, inaugurato e riaperto al culto nel 1985, dopo lunghi anni di chiusura per lavori di restauro. Sorto nel XIII secolo, amministrato dalla Confraternita N.S. del Rosario dei Turchini, celebra Limbania il 16 Giugno, in occasione della memoria liturgica, con una messa solenne. Limbania vi è ricordata inoltre la terza settimana di settembre, posticipando il giorno della festa e sagra (16 agosto), con diverse manifestazioni.

All’interno dell’Oratorio si ammira, oltre la nuova statua processionale posta nel 1986, un’edicola marmorea datata 1491, che effigia Limbania non più giovane, in abito da monaca, dono di un abbiente e generoso speziale. Da Voltri la devozione fu portata dai cavallari, dalla piazzetta Limbania di Borgo Cerusa, su verso il ripido sentiero della Cannellona, verso l’Ovadese e l’Acquese. La chiesetta S. Limbania è indicata nell’Atlante del Vinzoni.
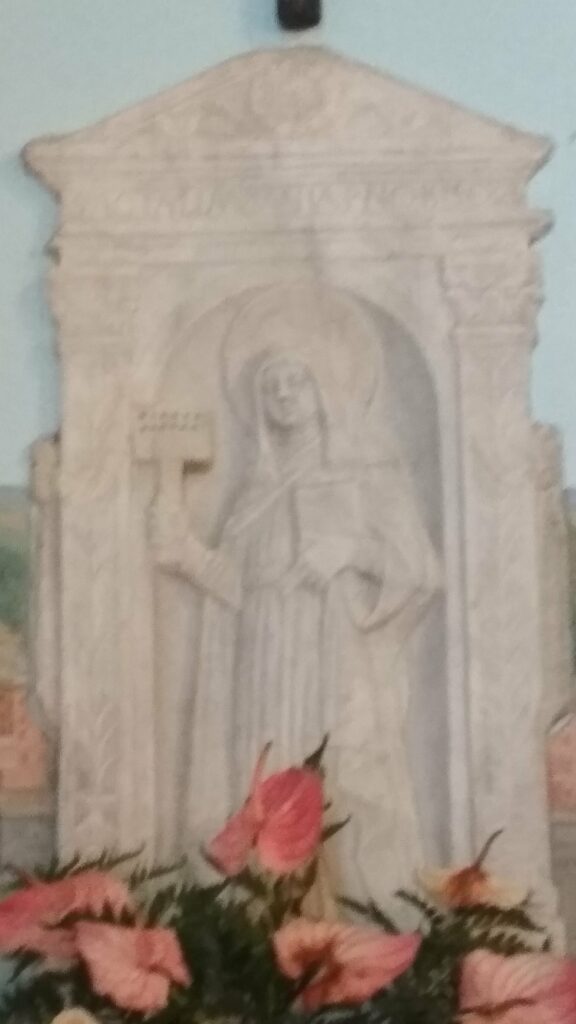
Gavi. L’oratorio dei Bianchi, di lontanissima origine, sede del Monte del grano, affrescato nella volta da G.B. Carlone, ospita, come già ricordato nel precedente articolo, una pregevole statua lignea di Limbania, di artista anonimo. L’Oratorio è fra le tappe del Cammino religioso, escursionistico ed enogastronomico di Santa Limbania, ideato e presentato nel 2004 dalle province di Genova e di Alessandria.
La statua lignea settecentesca si eleva austera, vigorosa, solenne, nei colori del grigio e avorio. Il volto, fiero, è stretto dal sottogola; dei capelli si intuisce una linea scura sulla fronte mentre lo sguardo è distante, fermo e assorto. Nella mano destra, impugnato come un testimone, uno strano utensile (la tessitura, plausibile attività svolta al monastero, potrebbe spiegarne la presenza): «Et quella, che eccede ogni meraviglia, non contenta di flagelli e cilici, per il desiderio di quanto più poteva assomigliarsi al suo Sposo, e di render sangue, a chi trafitto di spine, versato aveva per lei copiosi rivi di sangue, avvertite (per non essere né veduta, né impedita) le ore, nelle quali usciva fuori di casa la sua Nutrice, che, come dissi, era rimasta in sua compagnia, e i servi del Monastero, ella con un pettine da lino dai ben acuti e pungenti ferri lacerava in modo compassionevole le innocenti e delicate sue membra» (Antonio Casamara, Vita, et miracoli di Santa Limbania vergine, monaca del monastero di S. Tomaso di Genoua, 1683, p. 45)). La mano sinistra sorregge forte il Vangelo.

Un manto scuro avvolge il corpo in un incrocio sul davanti, al modo delle monache, come uno scapolare, a mostrare appena la veste chiara. Di anonimo scultore, è custodita nell’Oratorio dei bianchi fin dal Settecento, salvata dalle scorrerie napoleoniche.
Rocca Grimalda. La chiesa, denominata Santa Limbania dalla seconda metà del Seicento, sorge su un imponente sperone roccioso che domina il corso del fiume Orba. La dedicazione alla monaca cipriota, oggetto di venerazione a Genova dal XIV secolo, si deve probabilmente alla famiglia Grimaldi, feudatari di Rocca; inoltre, Santa Limbania era la patrona dei mulattieri, che facevano la spola tra e Genova e Rocca Grimalda, partendo dall’omonima chiesetta di Voltri. All’interno è una statua lignea, sdraiata, protetta in un altare. I suoi piedi sono oltremodo consumati poiché le madri usavano staccarne una piccola scheggia, da mandare ai figli in guerra. La chiesetta è aperta il 15 agosto.

Castelleto d’Orba. C’è un’absidiola, parte restante di una chiesetta più ampia, con affreschi cinquecenteschi raffiguranti Limbania, dai graziosi lineamenti, in ampio abito monacale, di foggia rinascimentale, ai lati di una Madonna con Bambino. A destra con le mani giunte in preghiera, a sinistra col pettine da tessitura, guardato come in uno specchio. L’absidiola si trova nei pressi della chiesetta di San Rocco, nella vecchia via per Lerma, uno degli antichi itinerari verso il mare, accanto alla fonte che porta il nome Limbania, sulle sponde del rio Albedosa.

- Secondo la leggenda, la campana era arrivata da Cipro, dalla stessa casa di Limbania e approdata inspiegabilmente nell’arena ai piedi del monastero, dove le suore la raccolsero. «E nell’anno millecinquecentosessantadue, una Campana, la quale già tant’anni quasi per divino volere fu al lido del Mare alla ripa del Monasterio improvvisamente ritrovata, venne da quelle Reverende Madri con occasione di ristorarla a questa gloriosa Santa dedicata, nella quale ancora fecero imprimere l’immagine, e il nome di lei». (Casamara, op. cit. pp 5-6) ↩︎