Il Canzoniere della Resistenza. Un (quasi) inedito di Umberto Eco

“La Provincia di Alessandria” era il bollettino mensile dell’Ente Provincia. Ma, fra gli anni Cinquanta e Ottanta, fu anche una vera e propria rivista di cultura, sulle cui pagine comparvero riflessioni di impianto politico ed economico, brevi saggi a carattere storico, articoli dedicati al patrimonio artistico e architettonico della provincia. E fu la palestra in cui si esercitarono studiosi e intellettuali che divennero assai importanti nel panorama culturale locale e, non di rado, anche sulla scena nazionale e internazionale.
Nel numero di aprile 1961 della rivista, comparve un lungo articolo sul canto partigiano firmato da Umberto Eco, allora ventinovenne fresco di incarico universitario e in procinto di dare inizio alla sua lunga bibliografia di saggi e romanzi (Diario Minimo è del 1963).
In quegli anni Eco studiò a fondo il folklore e la canzone popolare, collaborando all’attività di “Cantacronache”, un collettivo di musicisti e letterati che svolse importanti lavori di ricerca e di produzione teatrale e musicale (l’esito più noto di quell’esperienza fu probabilmente la canzone Oltre il ponte, con musica di Sergio Liberovici su testo di Italo Calvino).
L’articolo ritrovato su La Provincia di Alessandria è sicuramente uno dei suoi contributi più significativi riconducibili a quegli interessi e a quegli studi, ma è rimasto per decenni sepolto negli scaffali delle poche biblioteche che conservano la rivista. L’ho scoperto per caso, cercando altro, come non di rado accade.
Il saggio si presenta come recensione di un libro, ma il testo va ben oltre e offre interessanti riflessioni su temi ancora apertissimi: Eco ci esorta a non abbandonare l’esercizio della memoria; guarda con preoccupazione alla deriva “retorica” di cui già soffrivano le celebrazioni e certe narrazioni della Resistenza; Indica la necessità di studiare a fondo la mentalità partigiana, come punto d’osservazione indispensabile per capire l’Italia del dopoguerra.
E c’è, in quello scritto, anche molta e suggestiva memoria di Umberto Eco adolescente che osserva lo svolgersi della vicenda partigiana.
Un testo “quasi” inedito che conserva intatta la sua freschezza e attualità.
«Canti della resistenza italiana»: è il titolo di un volume apparso qualche mese fa presso le edizioni del Gallo[1]. Una raccolta di canzoni, testi e musica, quando la musica si è potuta rintracciare, quando chi la sapeva era ancora vivo. Dunque i partigiani cantavano. Sulle colline del Monferrato, sui monti dell’Ossola, nel Friuli, dopo essere sfuggiti ai rastrellamenti, raggiunte le zone più sicure, la sera, in qualche capanna, attorno al fuoco, cantavano. Ma noi sappiamo invece che cantavano i soldati della guerra di Secessione americana, che i sudisti suonavano «Dixie» e i conduttori di diligenze intonavano « Oh Susanna». I nostri amici più giovani, quelli che oggi fanno il Liceo o i primi anni dell’università, sanno che il fortino di Alamo si difese lungamente contro l’assalto del generale Santana, e che alla fine cedette, e vi morirono Davy Crocket e Jim Bowie. Essi sanno a memoria anche l’inno di quel Settimo Cavalleggeri che fu sterminato col Generale Custer, perché il cinema, la televisione, i rotocalchi li hanno a lungo informati su queste cose.
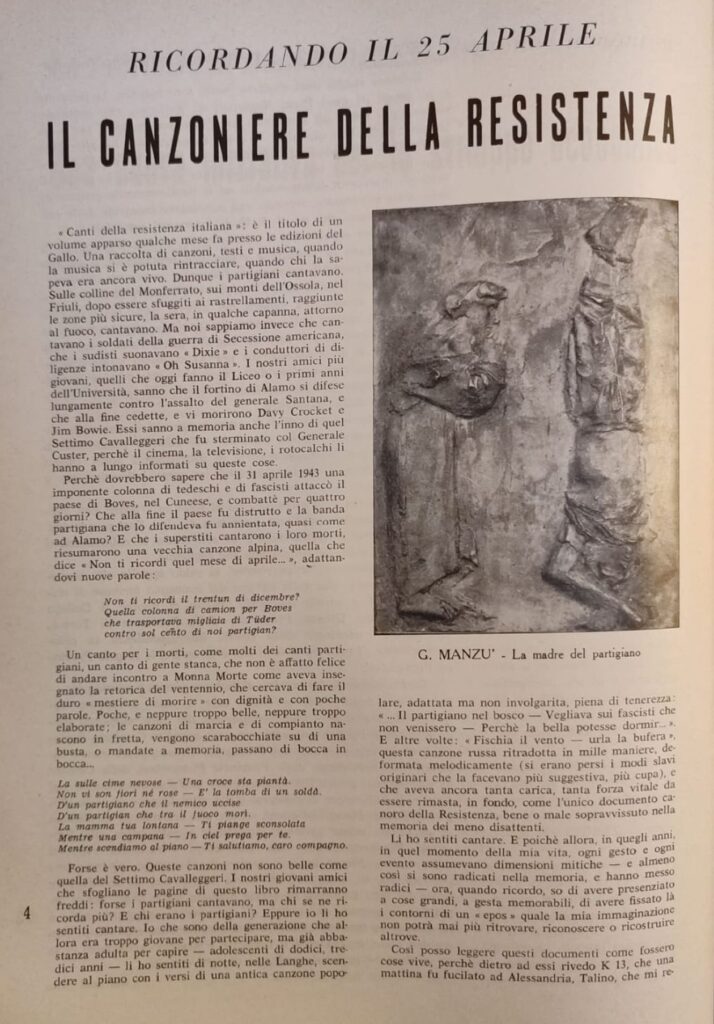
Perché dovrebbero sapere che il 31 dicembre 1943[2] una imponente colonna di tedeschi e di fascisti attaccò il paese di Boves, nel Cuneese, e combatté per quattro giorni? Che alla fine il paese fu distrutto e la banda partigiana che lo difendeva fu annientata, quasi come ad Alamo? E che i superstiti cantarono i loro morti, riesumarono una vecchia canzone alpina, quella che dice «Non ti ricordi quel mese di aprile…», adattandovi nuove parole:
Non ti ricordi il trentun di dicembre?
Quella colonna di camion per Boves
che trasportava migliaia di Tuder
contro sol cento di noi partigian?
Un canto per i morti, come molti dei canti partigiani, un canto di gente stanca, che non è affatto felice di andare incontro a Monna Morte come aveva insegnato la retorica del ventennio, che cercava di fare il duro «mestiere di morire» con dignità e con poche parole. Poche, e neppure troppo belle, neppure troppo elaborate; le canzoni di marcia e di compianto nascono in fretta, vengono scarabocchiate su di una busta, o mandate a memoria, passano di bocca in bocca…
La sulle cime nevose — Una croce sta piantà.
Non vi son fiori né rose — E’ la tomba di un soldà.
D’un partigiano che il nemico uccise
D’un partigian che tra il fuoco morì.
La mamma tua lontana — Ti piange sconsolata
Mentre una campana — In ciel prega per te.
Mentre scendiamo al piano — Ti salutiamo, caro compagno.
Forse è vero. Queste canzoni non sono belle come quella del Settimo Cavalleggeri. I nostri giovani amici che sfogliano le pagine di questo libro rimarranno freddi: forse i partigiani cantavano, ma chi se ne ricorda più? E chi erano i partigiani? Eppure io li ho sentiti cantare. Io che sono della generazione che allora era troppo giovane per partecipare, ma già abbastanza adulta per capire — adolescenti di dodici, tredici anni — li ho sentiti di notte, nelle Langhe, scendere al piano con i versi di una antica canzone popolare, adattata ma non involgarita, piena di tenerezza: «…Il partigiano nel bosco — Vegliava sui fascisti che non venissero — Perché la bella potesse dormir…». E altre volte: «Fischia il vento – urla la bufera», questa canzone russa ritradotta in mille maniere, deformata melodicamente (si erano persi i modi slavi originari che la facevano più suggestiva, più cupa), e che aveva ancora tanta carica, tanta forza vitale da essere rimasta, in fondo, come l’unico documento canoro della Resistenza, bene o male sopravvissuto nella memoria dei meno disattenti.

Li ho sentiti cantare. E poiché allora, in quegli anni, in quel momento della mia vita, ogni gesto e ogni evento assumevano dimensioni mitiche – e almeno così si sono radicati nella memoria, e hanno messo radici – ora, quando ricordo, so di avere presenziato a cose grandi, a gesta memorabili, di avere fissato là i contorni di un «epos» quale la mia immaginazione non potrà mai più ritrovare, riconoscere o ricostruire altrove.

Così posso leggere questi documenti come fossero cose vive, perché dietro ad essi rivedo K13, che una mattina fu fucilato ad Alessandria; Talino, che mi regalava i bossoli dello «sten», e una volta mi fece anche sparare un colpo in aria; e il Negus che dopo la liberazione di Alessandria rientrò trionfalmente a Nizza Monferrato seduto sul parafango di un dodge, con una barba che sembrava il leone del Ferrochina, scamiciato e sudato, che rideva con dei denti da far paura e stringeva tutte le mani che gli tendevano, perché si era detto che lo avevano ammazzato in combattimento e invece eccolo di nuovo, a sparare in aria con il mitra per far festa.
Così riacquistano sapore certe strofe spavalde che una certa Radio Libertà trasmetteva clandestinamente da Sala Biellese, alternando le provocazioni alle notizie di colpi di mano riusciti:
Val più un ribelle con l’itterizia che un generale della milizia

La polveriera di Alice Castello
Aveva colpi pel nostro macello…
Ma poiché siamo tutt’altro che buoi
Ora quei colpi li abbiamo qui noi!
Cari fascisti, gli alpini che armate
Vengon felici alle nostre brigate
C’è chi rastrella galline nostrane
perché ha paura che sian partigiane
Oppure, sull’aria di «Sul cappello»:
Le ragazze, le ragazze dì Valle Gesso
Son le nostre, son le nostre stelle alpine
Che con cuore, che con cuore di bambine
Fan l’amore, fan l’amore coi partigian…
0 ancora certe immagini come questa, figure che ho visto (e ammirato, forse adorato, Dio mio, con tutte le trepidazioni di una pubertà chiamata in causa…):
E più ancora posso capire queste altre canzoni, dove non c’è più alcuna spavalderia, ma solo spavento o dolore:
Se ad Intra odi il cannone
C’è qualcosa di tremendo
I patrioti stanno morendo
Sulla strada del Vadaa
Quando si è in rastrellamento
È un cammino traditore
E lì muore il più bel fiore
Della nostra gioventù.
In questi casi, anche musicalmente, si ricorreva alle melodie delle prime canzoni di protesta, apparse prima ancora dell’otto settembre, quei canti di alpini in cui non si esaltava la «bella morte» ma si piangevano i compagni; primo fra tutti quel «Sul ponte di Perati» nato sulle montagne di Grecia:

Lassù nel Pian del Cavallo
Bandiera Nera!
È morto il nostro Maso
Nel far la guerra…
La vien giù dalla montagna
L’è vestita a partigiana
Ha di fiamma la sottana
Ed ha al collo il tricolor
La montagna fu sua madre
Ed il bosco fu suo padre
Sue sorelle son le stelle
Che scintillano nel ciel.
Se la guarda un giovanotto
E l’invita a far l’amore
Lei gli mostra il tricolore,
È la fiamma del suo cuore!
Ma sullo stesso motivo il comandante Nuto Revelli concludeva con una strofa di battaglia poi divenuta come uno slogan:
Tedeschi e fascisti Fuori d’Italia!
Gridiamo a tutta forza
Pietà l’è morta! ».
Ora potrei chiudere il libro. Ho compiuto la mia esercitazione nei dolci territori della memoria. Mi sono fatto il tuffo salutare nella mitica foresta dell’infanzia, ho ritrovato volti e figure, gesti e parole, il crepitare delle mitragliatrici sulle colline, improvvisamente, nel gran sole del primo pomeriggio (poi di nuovo il silenzio).
Quanto agli amici più giovani – a quelli che Quanto agli amici più giovani – a quelli che potrebbero oggi essere miei allievi, o accanto a me in una festa di Capodanno – a loro rimane l’epopea di Alamo. Chi ha loro mai parlato d’altro? I libri di storia che si arrestano al trattato di Versailles? Le trasmissioni televisive? I genitori – con tutti i guai che hanno per la testa, andarsi ancora a mischiare di politica…? Così ci cresciamo intorno (noi troppo indulgenti nei giochi della memoria) una generazione senza memoria. Alla quale forse sarebbe persino pericoloso offrire all’improvviso il panorama di un folklore musicale spavaldo, tenero o eroico, che potrebbe troppo facilmente essere confuso con quello dei technicolor in circuito normale.

Non vogliamo affatto che alla tabula rasa della loro coscienza storica si sostituisca la immagine pittoresca di un grande «barbudo» all’italiana, dal grilletto facile, capace di cantare alla luna parole d’amore e di nostalgia. Non è questo che vorremmo. E lo sapevano già i partigiani, che tentavano, anche nelle loro canzoni, di far dell’antiretorica:
Il bersagliere ha cento penne
E l’alpino ne ha una sola
Il partigiano ne ha nessuna
E sta sui monti a guerreggiar…
Dunque vorremmo che si sapesse di una Resistenza senza penne, con canzoni brutte e prese a prestito dal repertorio popolare, o messe giù con toni deamicisiani da un maestro di scuola o da un ragioniere di banca fuggito sui monti perché aveva capito che bisognava fare così. A sedici anni dalla Liberazione possiamo sperare che poco a poco questo accada, che i giovani incomincino a sapere e capire. I più vecchi a ricordare, se sarà il caso.
Ma quello che abbiamo incominciato era un discorso sui canti della Resistenza, niente altro. E ad essi si può tornare per concludere, cercando di vederli non con gli occhi della nostalgia o col desiderio del pittoresco, ma con il distacco critico dello storico. Come documenti che possono comunque insegnarci qualcosa.

Roberto Leydi, nella sua lunga introduzione al volume (un notevole saggio di etnologia musicale, dove il problema specifico viene inquadrato in un sensibile discorso sulla musica popolare in Italia) procede ad una classificazione dei vari tipi di canti partigiani: quelli derivati da antichi canti anarchici e rivoluzionari, quelli mutuati dalla tradizione risorgimentale, quelli modellati sul repertorio popolare comune, quelli derivati dal folklore alpino del ’15-’18, eccetera. La prima osservazione che ci è dato di fare subito, per intanto è la seguente: che la guerra partigiana ha avuto in fondo un folklore popolare, sia pure di origine impura, molto più ricco delle guerre risorgimentali. In queste abbondavano i canti di tradizione colta, i prodotti dei vari Mercantini e Mameli, espressione di una rivoluzione dovuta alle classi borghesi, di moti a cui le classi popolari rimasero sostanzialmente estranee, salvo casi tipici e clamorosi. Leydi trova anzi nel repertorio popolare ottocentesco canzoni che potremmo definire «qualunquiste», ispirate a un generico pessimismo nei confronti sia degli austriaci che dei piemontesi, dei francesi, del Papa o di Garibaldi. Il canto spontaneo del soldato che portava zaino in spalla era piuttosto ispirato a un certo fatalismo, al ricordo della bella lasciata al villaggio. Il secondo momento rivoluzionario della nostra storia, quello appunto della Resistenza, manifesta invece la sua natura popolare proprio nel non aver saputo elaborare un «canzoniere» organizzato, nell’avere in fondo i partigiani cantato le vecchie canzoni delle loro valli o delle loro montagne, con poche aggiunte, con maldestri adattamenti. La gloria di questo «canzoniere» partigiano sta appunto nella sua povertà di fronte alla ricchezza del «canzoniere» ufficiale fascista, fatto con musiche originali e versi altisonanti dai vari Ruccione[3] della situazione. Tuttavia, all’interno di questo «corpus» folkloristico così prezioso, proprio perché così inorganico, possiamo già trovare i germi di contraddizioni che gravarono sulla Resistenza stessa e sul costume italiano di dopo (quasi le chiavi, in fondo, di quello smemoramento che si lamentava prima). Infatti, accanto alle melodie di origine folkloristica, troviamo da un lato le canzoni dei gruppi comunisti, assunte dalla tradizione rivoluzionaria e operaia, canzoni con una loro forza non priva di retorica, ma comunque con una chiara coscienza ideologica; dall’altro lato abbiamo invece un fenomeno piuttosto curioso: i partigiani prendevano quasi di peso i modi linguistici, formulari retorici assimilati durante il ventennio, e li ritraducevano in termini di resistenza al tedesco.

C’è un episodio del film «Tutti a casa», in cui il sottotenente Alberto Sordi incontra in un casolare un capitano che sta fuggendo in borghese; il giovane sottotenente ha ormai capito che con 1’8 settembre crollava un castello di cartapesta, fatto di illusioni e di equivoci, e quindi non si scandalizza quando il capitano lo assale dicendo che alla fin fine erano proprio loro, i giovani, che erano responsabili di quanto succedeva, loro che erano andati baldanzosamente a manifestare per Nizza italiana. Il sottotenente reagisce, afferma di essere stato sempre contrario al regime, di non avere mai approvalo nulla… Poi si ferma un istante con una di quelle espressioni dubbiose ingenue e filistee in cui Sordi è maestro, e domanda: «…Però Nizza era italiana, non è vero?…».
Tutto qui. Certi abiti mentali non si perdono facilmente anche se sopravviene un atto di onestà, di chiarezza. I comandanti partigiani che pieni di buone intenzioni stilavano per i loro uomini carduccianesimi e dannunzianesimi di ripiego, (comprendendo infine che anche la «carica» retorica ha una sua validità per gente che rischia ogni giorno la vita) erano ancora vittime, nella loro onestà, di antiche tare ereditarie del costume nazionale. Le stavano scontando a prezzo della propria pelle, e tuttavia le perpetuavano, le consegnavano al dopoguerra, invito ad ogni pigrizia, e ad ogni smemoratezza, perché le formule vuote sono il narcotico da cui nessun Charles Siragusa[4] potrà mai liberarci.

Là dove questi canti, riesumati, ci indicano la presenza di un moto popolare che stava prendendo forma cerchiamo ora le radici della nostra società democratica; ma dove ci indicano la presenza di un entusiasmo generoso quanto sprovvisto di chiara coscienza storica, cerchiamo almeno una indicazione per il nostro compito di cittadini, oggi. Così anche un canzoniere può diventare, per gli italiani consapevoli, esortazione alle storie.
Umberto Eco
[1] In realtà il volume dal titolo “Canti della Resistenza italiana. Raccolti e annotati da Tito Romano e Giorgio Solza con una introduzione di Roberto Leydi” è stato pubblicato nel 1960 dalle Edizioni Avanti!, nella collana Il Gallo Grande.
[2] Nel testo: “31 aprile 1943”, evidente refuso redazionale.
A Boves, domenica 19 settembre 1943, i nazisti perpetrarono il primo eccidio della storia della Resistenza italiana. Un secondo rastrellamento-rappresaglia ebbe luogo invece tra il 31 dicembre 1943 e il 3 gennaio 1944.
[3] Mario Ruccione fu uno dei compositori più noti dell’epoca fascista. A lui si devono molte canzoni in auge negli anni Trenta e Quaranta, ma divenne anche famoso come compositore di regime poiché scrisse la musica per molte canzoni di chiara impronta fascista, tra esse “Faccetta nera” e “La Saga di Giarabub”. Nel dopoguerra continuò la propria attività musicale. Come compositore vinse due Festival di Sanremo (con “Buongiorno Tristezza”, nel 1955, e con “Corde della mia chitarra”, nel 1957).
[4] Charles Siragusa, investigatore, nato a New York nel 1913 da genitori siciliani. All’apice della sua carriera fu al vertice della Polizia Criminale degli Stati Uniti. Riportò le sue esperienze di vita lavorativa, e i suoi successi nella lotta al traffico di droga, in un libro di memorie dal titolo The trail of poppj, behind the mask of di mafia, tradotto in Italia col titolo La pista del papavero, (Mursia, 1968).

